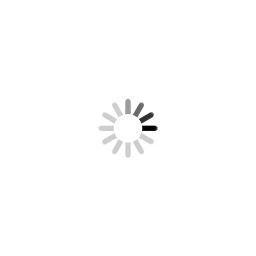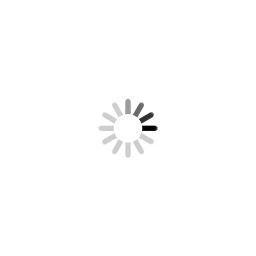Abbiamo letto per la prima volta il testo nell’estate del 2018. Il titolo era diverso, così come buona parte delle parole. Eppure, già allora, tra le battute, riuscivamo a respirare un senso di profondo smarrimento: un’inquietudine che ci accomunava e ci costringeva a fare i conti con i nostri sguardi sui rapporti umani più elementari. Quella sera non abbiamo indagato oltre. C’era bisogno di tempo e di nuovi incontri per capire come unire le nostre esperienze. Così, mesi dopo, è nato il primo tentativo di dare corpo ad uno spettacolo la cui creazione ha attraversato due anni, cambiando volti e forme, ma cercando di preservare e proteggere sempre la stessa inquietudine.
La drammaturgia imponeva un compito: affidarsi completamente alle parole, lasciare che il testo guidasse e si imponesse, abbandonandosi al dramma di dover abitare un incubo logico. Così, nel caos di un impianto testuale che si diverte a forzare l’azione scenica, la nostra necessità era di portare alla luce la crudeltà di quel linguaggio familiare che deve trasmettersi ad ogni costo, finanche prendendo vita propria. Il quadro dello spettacolo allora ci è parso più nitido: nell’estrema frammentazione delle relazioni, la disperazione di un padre nasce nell’avvertire il vuoto dopo di sé. Questo è quello che vive anche il Padre che abita la nostra scena: la sua è la crisi di chi non ha altro scopo se non lasciarsi in eredità, come assecondando una dialettica violenta e antica. E se il proprio Figlio crolla nella solitudine, nella desolazione di una realtà che non riesce più a riconoscere e a descrivere, quella stessa ineluttabile brutalità si manifesta in scena e guida il genitore verso un atto assurdo. Comparirà un nuovo figlio, una nuova promessa, una nuova speranza per emergere dal buio. In tutto questo paesaggio desolato, freddo e carico di orrore, come una scena del crimine, la Madre cerca di elaborare il lutto, di adattarsi alle parole che le vengono indicate: vive il dolore di chi non ha un proprio fine se non quello di cercare di far coesistere i fini altrui, trasformandosi in artefice, complice e succube della tragedia di famiglia. Ma è una tragedia anche di linguaggio, in cui il testo stesso, proiettato sul fondo, traghetta gli interpreti verso un destino inevitabile, così inevitabile da poter essere solo commentato, ridicolizzato o enfatizzato, come all’interno di una sit-com o di una soap opera. Alla fine ciò che si deve compiere è il sacrificio del Figlio, come in un testo sacro, ma con l’indifferenza di una vittima che non trova consolazione perché sceglie di non appartenere a quel mondo.