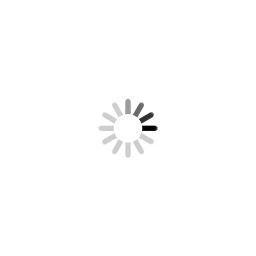La signora camminava davanti a me, testa grigia e passi tra altre teste e altri passi. Si è fermata. Ha tolto con cura dei rami secchi da una siepe di un cancello di un palazzo qualunque.
Ho pensato, guarda, c’è chi tiene alla bellezza di tutti, alle cose che migliorano il tempo, a che lo sguardo si appoggi sull’armonia e non sul disordine, guarda.
Ho pensato, no, io no, non lo faccio.
Poi l’ho vista entrare nel cancello di quella siepe di quel palazzo.
Il suo palazzo.
Ho pensato, c’è sempre dell’interesse nella bontà.
E l’ho trovato un pensiero rassicurante.
Non vorrei dirlo, non avrei dovuto dirlo, ma quel palazzo è anche il mio.
Uso il possessivo in modo improprio, perché non ha nulla di mio; non ho deciso il colore della facciata, non ho scelto la forma e l’anonimo grigio del cancello, non avevo notato, fino a poco tempo fa, la siepe dietro il cancello.
Perché devo appropriarmi della sua mano su quei rami, perché ho subìto immediatamente il fascino e l’arroganza di quel tentativo di restituire una stupida perfezione allo stato delle cose?
Ecco, ora, sì, ora l’ho persa. Finalmente. È scomparsa nel suo palazzo.
Da qui, ed era ora, posso non vederla, e lo trovo un pensiero rassicurante.
E questo perché, lo ammetto, trovo sempre rassicurante scoprire che una cosa non mi appartiene. Che si tratti di un cancello o di una siepe o di una certa insopportabile cura verso il mondo (del resto nemmeno quello posseggo, il mondo) io preferisco non dovermi occupare.
E di quello che non hai, di certo non ti occupi. Che meraviglia.
Da qui, credo, il mio misto di stupore e momentanea ammirazione per quella vecchia. Una persona che non possiede, eppure ha cura,
Fortunatamente è stato solo un attimo. Lei considera di sua proprietà questo palazzo, cosa che non condivido ma certo non posso controllare, e quindi sistema la siepe, non è diversa dagli altri.
Rimane, però, che sia diversa da me. Io ho piena consapevolezza di quello che non ho e, quello che non ho, lo scelgo.
Lo scelgo quotidianamente, lo sai, e sai anche che questo è il presupposto della nostra relazione.
Mi hai stupito, infatti, quando mi hai parlato del tuo cane. Tanto per iniziare non credo possa essere tuo, in senso letterale, intendo, in generale i cani appartengono alla razza dei cani e, in particolare, alle loro madri cagne che li vanno a partorire in qualche angolo. In secondo luogo, trovo che sia un vero attentato al patto che abbiamo firmato, alla nostra condivisa e voluta “legge del non possesso”, allo stile di vita che abbiamo scelto e, cosa ben più grave, alla nostra unicità.
Io e te ci siamo incontrati e ci siamo compresi esattamente nel momento in cui ci siamo incontrati.
Io non ho, io non ti ho. Io non ti ho perché io non ho.
Questa è la prima regola. Che tu abbia deciso di infrangerla per un cane mi addolora e mi affatica.
Ma ti dirò, se è vero che intellettualmente mi affatica è anche vero che so perfettamente che il dolore sarà del tutto transitorio.
Ci si duole per ciò che si è perso, e quindi si è posseduto, ma io so di non possedere nulla, nemmeno la legge che ho scritto.
In ogni caso, al di là della mia innegabile lucidità e capacità analitica, in questo istante così dirompente anche grazie al (fortunatamente) non gratuito gesto della vecchia signora, qualcosa mi sfugge.
E quello che mi sfugge sei tu.
Certo, se ti fosse sfuggito quel particolare, mio dio, quel particolare “linguistico” (non trovo di meglio), non staremmo qui, ora, a rinfacciarci. Lo vedi, la mia lingua si sta imbruttendo, eppure hai notato quello stupido, per me insignificante possessivo. Sì, in effetti ci stiamo rinfacciando. Che significa, esattamente? Non credo abbia a che fare con l’insultarsi reciprocamente con le solite rivendicazioni. Mi è nata come l’impressione (non so dirlo meglio, la mia lingua si sta imbruttendo), l’impressione, dicevo, che ci rinfacciamo di proposito, io mi rinfaccio in te e tu in me. Non riusciamo neanche ad essere veri antagonisti. Sì, ora tu dirai che sono cazzate da filosofo a buon mercato (uso frasi fatte, la mia lingua si sta imbruttendo), quelle battaglie sulla lingua che tanto piacciono ai francesi e ai circoli del dopo-lavoro letterario. Il punto è. Volevo dire: il punto centrale è. Voglio dire: come posso sfuggirti se dici di non avere nulla? Se vale la legge del non possesso che sia legge fino in fondo. Non posso che sfuggirti, non trovi?
Certo, io ho un cane, maledetto possessivo, non farci caso, e una vecchia di fronte. Tutti i giorni. Anche ora. O meglio, guardo un cane e una vecchia. Tutti i giorni. Anche ora. Perché non dovrebbe possedere nulla? Perché non dovrebbe avere, anche lei, una qualche forma di interesse? Chi siamo noi per decidere che un atto sia gratuito? Guardala meglio. Eccola di nuovo. Sono sicuro che anche tu sei alla finestra. Penultimo piano, in quel palazzo che credevamo nostro.
La signora con i capelli grigi che abitava nel palazzo con il cancello grigio con la siepe verde con i rami secchi si trovava lì da poco più di due mesi. Nella sua vita aveva cambiato circa diciassette case, del numero preciso non era certa nemmeno lei. La prima era stata quella dei suoi genitori, la seconda quella dove aveva abitato con la sua amica Laura, la terza quella condivisa con Antonio (la convivenza, qui, era andata per le lunghe), tra la quarta e la tredicesima aveva perso il conto perché i traslochi erano stati troppo frequenti e troppo repentini, così come l’alternarsi delle vie e dei palazzi e dei cancelli. Sull’andare e venire delle convivenze e delle solitudini, poi, preferiva non soffermarsi.
La quattordicesima comunque era stata una bella casa. La quindicesima e la sedicesima anche. La diciassettesima invece, quella attuale, la detestava.
Innanzitutto, era perennemente disturbata dall’abbaio di un cane di cui non era riuscita ad identificare il o la proprietaria. Se ci fosse riuscita, e sperava di riuscirci, sicuramente avrebbe trovato il modo di farlo tacere, il cane. Inoltre, non le piaceva nulla, trovava che l’ingresso fosse triste e puzzolente, l’ascensore non lo usava mai (chissà chi aveva schiacciato i pulsanti prima di lei) e il giardino era… Ecco, non sapeva nemmeno come definirlo, il giardino. Era un fazzoletto di terra e catrame, un aborto di giardino, un abominio di giardino, un insulto alla bellezza di tutti gli altri giardini del mondo.
Perciò era ossessionata dalla siepe. Almeno la siepe doveva essere in ordine, pulita, la siepe non doveva seccare, non doveva perdere le foglie, doveva resistere e ripararla dalla vergogna di vivere in un così orrendo palazzo con quell’orrendo cancello con quell’osceno giardino.
Così se ne prendeva cura, nei limiti del possibile, lo faceva per sé, non per gli altri, degli altri non si era mai molto interessata e non aveva intenzione di farlo ora, lo faceva perché teneva al decoro, al suo decoro. E lo faceva anche perché, mentre strappava i rami secchi, poteva curiosare nelle cassette delle lettere che, per una ragione a lei sconosciuta, erano state posizionate proprio lì, un po’ nascoste dalle foglie, agganciate alle sbarre del cancello, senza nessuna riservatezza, esposte alle pubblicità e ai suoi occhi.
Era stato così che aveva scoperto che la cassetta ventidue si poteva aprire senza chiave. E, dato che si poteva aprire senza chiave, non doveva certo sentirsi in colpa quando, per passare il tempo, prendeva una lettera da leggere.
Si era ritenuta fortunata, tra l’altro, in quella cassetta c’erano sempre lettere da leggere. Lettere curiose, lettere senza francobollo, lettere il cui mittente era solo A.
E il cui destinatario era, ugualmente, sempre e solo A.
Nonostante tutto, non bisogna pensare che lei si occupasse di numerologia, o che facesse un qualche affidamento sulla cabala o affini. Contare e stabilire un numero per le cose o gli eventi era semplicemente, per lei, un fatto naturale. Quell’abitudine che da bambina la divertiva, e che creava, in qualche modo, una distanza tra lei stessa e il mondo, era ora diventata poco più che un esercizio d’allenamento per la memoria. Nella solitudine, talvolta, i numeri sostituiscono le parole nel dare un senso alle cose e tenerle con sé. La sequenza che si era appena stabilita nella sua mente, il diciassette insieme al ventidue, non le provocava che una strana ironia nei confronti di quegli anziani, magari, come si dice, suoi coetanei,
Ho pensato che l’età è un pregiudizio. Niente di nuovo, mi dirai. Sì, ma…accorgersene davvero, essere sorpresi da questo pensiero, all’improvviso di una giornata qualunque, ti rende…sì, vecchio. Non ho altre parole per dirlo. Vecchio come
quegli anziani che si sarebbero precipitati a sfidare la sorte in qualche tabaccheria a portata di piedi, tornandosene a casa inevitabilmente sconfitti. Del resto, perché avrebbe dovuto giocarsi due spiccioli su un numero così “ontologicamente” sfortunato come il diciassette, se, in quella precisa circostanza, lo schifo di ultimo appartamento e la sua astrazione numerica parevano persino confermare le credenze della superstizione? No, tutto questo non faceva il caso suo. Piuttosto le interessava, ora, la singolare associazione tra mittente e destinatario. Non tanto il fatto che un mittente potesse essere il destinatario delle sue stesse lettere, certo, questo è, per certe persone, naturale, quanto la scarsa cura, a suo avviso, che l’altro umano aveva riposto nell’assegnare a se stesso quella A, come se non avesse avuto tempo per proseguire nell’alfabeto, o, peggio, come se, per scarsa immaginazione, si volesse indicare come “Anonimo” e rinunciare allo sforzo di darsi un nome. Ecco, si disse, questo è inaccettabile, quanto questo palazzo, quest’ultimo stupido trasloco, questa città, e, fino a poco fa, questa siepe. Così, mentre era arrivata ad una sorta di conclusione di quel futile ragionamento, fu sorpresa ancora una volta dall’abbaiare del cane.
Guardò in alto, ma fu di nuovo assalita da un altro pensiero che la distolse da quel fastidio, ovvero, per l’esattezza, quanto è stupido pensare che un vecchio debba affezionarsi a un cane, quanto è ridicolo anche supporre che l’abbaio di un cane non sia altro che, appunto, un fastidio, l’ennesima imperfezione naturale che, ora, ha reso inutile anche la cura della siepe.
Tornò a guardare in alto, e, senza neppure accorgersene, cominciò a dare un numero a tutti gli appartamenti che vedeva di fronte a sé. Si fermò al settimo appartamento, interno A. Sorrise, al contempo stupita e fiera del suo intuito, rassicurata dalla sua infantile attitudine numerica, dalla sua capacità di vedere dettagli che a tutti gli altri rimanevano oscuri, nascosti. Sorrise.
Fino a quando non sentì suonare il citofono.
Ecco, il citofono non se lo aspettava. Nessuno sapeva dove abitava, a parte il postino (o forse neanche lui, perché posta, lei, non ne riceveva), di amici ne aveva avuti, ma adesso non ne ricordava nemmeno il nome, di parenti, conoscenti, nemici o pretendenti men che meno.
Citofono.
Non rispondo.
Citofono.
Che diavolo vogliono.
Citofono.
Oddio, sanno che abito qui (nello schifo di palazzo ascensore cancello giardino).
Citofono.
Si? Chi è?
Signora, senta, il cane è suo?
No.
(Aspetta, di quale cane sta parlando?)
Scusi, intende il cane che si sente abbaiare spesso?
Non lo so signora, intendo il cane che si sente abbaiare adesso e scorrazza qui in giardino che è proibito lasciare i cani liberi nel giardino condominiale intendo il cane che sto tenendo per il collare e che non mi risulta appartenere a nessuno perché fino a quando lei non è venuta ad abitare qui un cane in giardino non si era mai visto.
Allora, il cane è suo o no?
Sì, è mio.
Pausa.
Signora?
Non aveva senso, non aveva alcun senso, ma le era venuto così, d’impulso, quasi le pareva di non averlo detto eppure lo aveva detto. Il cane non era suo, prima del citofono, ma da quel momento lo era. Per un semplice pronome: mio. In fondo era solo una questione linguistica. Tutto è una questione linguistica, pensò, come per quelle lettere, le lettere da A a A. Che erano diventate sue nel momento in cui le aveva trovate incustodite in quella cassetta delle lettere incustodita. Lettere senza nome, senza firma, senza amore. Lettere senza padre (la signora amava i parossismi linguistici). Proprio come il cane, senza guinzaglio, senza padrone, senza cura. Senza la qualifica di un possessivo.
Ah, bene, signora. Allora se lo venga a prendere, il suo cane.
Pausa.
Signora, c’è ancora?