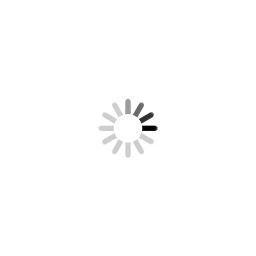Puntata 7
Non seppe dire quanto rimase nel suo studio, al PC. Seppe solo che quando scese le scale per tornare alla festicciola che lei e la sua compagna avevano indetto per il vicino, lo trovò tutto solo al canapè accanto alla finestra. Guardava fuori, le mani pugno su pugno sulla spalliera, la testa appoggiata sui pugni, le sopracciglia alzate in quello che sembrava un sorriso senza labbra. Guardava verso il giardino, oltre la siepe, oltre il buco oltre la siepe; guardava casa sua. Che stava vuota, buia, lì.
“Mi dispiace.”
Il vicino si riscosse, si voltò verso la giovane donna che aveva appena parlato. Aveva gli occhi acquosi di chi si sta per addormentare, o di chi ha bevuto troppo.
“Dov’è finita…?”
“Alice?” – era il nome della donna più matura.
“Non lo so. A dormire, credo.”
Le sembrò strano, e al tempo stesso perfettamente naturale. In fondo era notte, anzi, era tardi, c’era stato il vino, e poi il resto, c’erano state le chiacchiere sul vicinato e il giocare con il cane, c’era stato il tour della casa, c’era stato il dirsi che dovevano organizzarsi più spesso, c’era stato il perché non l’abbiamo fatto prima.
Ma non c’era stato un accenno a ciò che era successo il pomeriggio stesso, a quel pianto, a quella confessione di uomo abbandonato, non c’era stato il minimo riferimento al fatto che fosse un poeta, né poesie declamate attorno a un tavolo, o lettere d’amore e di odio cantate con un piede arrogante sul tavolo, a squarciagola, mentre la notte bussava silenziosa alle porte e alle finestre.
Era stata, in fin dei conti, una banale serata di vicinato.
Ora però erano vicini in un altro senso. Lei gli si era seduta accanto, si era messa nella sua stessa posizione, pugno su pugno, mento sui pugni, a guardare verso la sua casa.
“Ne senti la mancanza. Di lei, dico.”
“Sì.”
“Di già.”
“Sì.”
“Eravate sposati?”
“No.”
“Fidanzati?”
“Non più.”
“E ci si sente così da subito?”
“Così come?”
“Incompleti.”
“Sì.”
Un silenzio.
“Non sono mai stata lasciata.”
Lui rise “È strano.”
“È strano?”
Lei lo guardò.
“Non mi sono mai sentita… incompleta. Questo dico.”
Poi un altro silenzio.
“Alice mi ha detto che sei un poeta.”
“Non è quello che sono, è quello che faccio.”
La giovane rise: “È la tipica risposta di un poeta.”
Lui anche.
Si voltarono, la casa vuota nell’oscurità si voltò anch’essa.
“Anche io scrivo.” Ammise la ragazza, non senza compiacimento.
“Una poetessa?”
“Mi piace di più poeta, una poeta.”
“Ah.”
“Una sillaba in meno. Dà qualcosa in più.”
“Cosa?”
“Una possibilità. Cioè, no. A parte le cazzate, scrivo e basta, così.”
E fece un gesto in aria poco convinto, com’era poco convinta lei stessa di dire che scriveva, o che sapeva scrivere.
“È un modo per… sai quello che si dice.”
“Cosa si dice?”
“Sfogarmi? Esprimermi? Si fa fatica a dirlo.”
“Per questo si scrive. Perché non si riesce a dire.”
“Be’, allora io non riesco neanche a scriverlo. Sono dislessica.”
A entrambi una piccola risata morì prima dei denti, emerse come un sorriso, un espiro più marcato, un abbassare gli occhi per non incrociarli.
“Siete qui da poco. Trasferite da un’altra città o eravate già in zona?”
La giovane deglutì.
“È così.”
“Non avete un accento strano.”
“No, diciamo, come hai detto tu? Eravamo già in zona, sì, volevamo… una casa più grande, voleva una casa più grande, un giardino, per il cane, sai…”
“Ah, sì, il cane.”
“Quelle cose da classica famigliola lesbica.”
Risero.
“Faremo sistemare una rete dietro la siepe… per il cane, dico…”
“No, è bello che la senta come casa, è un bravo cane, mi piace quando viene a trovarmi.”
“Sì, è un bravo cane.”
“Sembra quasi umano, sai come si dice… no anzi, sembra proprio un cane, almeno lui non scappa, non va via.” Rise, ma solo lui. Ritornò con lo sguardo verso la casa buia e vuota. “E poi… se dev’essere una scusa perché mi veniate a trovare…”
“Perché ti ha lasciato?”
“Come?”
“È stata Alice. A dirmelo. Scusala. Insomma, è per questo che sei qui, ti ha invitato perché ti ha visto così triste, ma poi sei arrivato e non eri triste, e abbiamo evitato di parlarne tutta la serata, e io ti ho osservato senza chiederti niente, ho cercato qualcosa che non andasse, qualcosa che mi facesse dire Anche io se fossi in lei prenderei la macchina, lo lascerei a piangere, solo in casa, in una casa grande e vuota, ero sicura di trovare qualche segno in te, una minaccia, un pericolo. Io non volevo che tu venissi. È stata Alice a invitarti, io… e invece io non ho visto niente, non c’era niente in te, non c’è niente in te, che non va intendo, sei uno a posto, uno carino, si dice così, io scriverei così di te, uno carino, e allora mi sono detta che ci doveva essere qualcosa più giù, ma poi, voglio dire poi, quando sono salita, ti ho perso di vista, e a un certo punto mi sono resa conto che non ricordavo che faccia avevi, ti avevo appena visto, ma eri scomparso, e poi ancora… No. Niente. Sono scesa ed eri qui. E ti ho visto. Carino. Perché ti ha lasciato?”
Aveva parlato senza fermarsi, senza quasi respirare. Temeva di aver detto troppo, e che quello che sarebbe seguito sarebbe stato l’ennesimo silenzio, come una pausa teatrale calcolata sui battere, un po’ troppo lunga insomma, un po’ desolante. Invece:
“È come chiederti perché scrivi. Non si può dire.”
“Sì che posso. Scrivo per tenermi lontana dai guai.”
Un qualcosa si mosse negli occhi di lui, si posò sui polsi di lei. “Guai” ripeté.
“Hai mai paura che quello che scrivi possa essere realtà?”
Fu allora che anche lui la vide. La vide come l’aveva vista Alice nel suo salotto, nella fotografia sul caminetto. La somiglianza, anzi l’identità. Stessi occhi, stessi capelli, stesse labbra, stessa essenza di lei senza di lei.
Un tremito nelle labbra fu il segnale al corpo dell’altro che doveva avvicinarsi, sentirne il calore del volto sul suo, perdersi nell’odore, stenderla e fare l’amore lì, davanti alla finestra, al cospetto della notte e del vuoto.
Una lingua scivolò sul suo viso, bagnandolo.
Nessuno dei due si era accorto che dalle scale era sceso il cane di casa, che scondinzolando, innocentemente, era saltato con le zampe anteriori sul canapè, addosso al poeta.
Dietro al cane, la sua altra padrona, Alice, si stagliava nell’androne come una sonnambula.
“Atreju. Vieni qui.”
La giovane si rese conto immediatamente di cosa dovesse sembrare la scena che Alice aveva interrotto. Nondimeno, prese a sorridere, si alzò, andò verso di lei con una voce carezzevole.
“Pensavo che fossi andata a dormire.”
“Anche io.”
“L’ho… trovato qui, stavamo parlando.”
“È un uomo triste.”
“Lo hai lasciato solo.”
“Lo siamo tutti.”
Perché diceva così? Classica scena di gelosia da romanzo? O ancora meglio, da serie tv romantica, una miccia che si accende nel buio di una famiglia, una rivelazione, poi un conflitto, poi una lunga corsa a riconquistare l’amata, perdersi tra le sue braccia, ripetere “è tutto a posto ora, è tutto a posto.”
Invece sul volto di Alice riprese vita un sorriso da ospite cordiale, un’espressione da è tutto a posto davvero, e alla giovane bastò questo per rincuorarsi.
“Io dovrei andare” disse il poeta.
“No. Non è tardi. Ho voglia di bere qualcosa.” Rispose Alice.
“E poi…” non c’è nessuno che ti aspetta “E poi… e poi non ci hai ancora letto niente, stavamo giusto parlando, non è vero? Di poesia.” Disse la ragazza.
“Poesia. Un po’ di poesia ci farà bene.”
Sulla tavola ancora imbandita, i resti di cibo nei piatti avevano assunto forme secche e astratte di nostalgie represse. Una crema di avocado che si ossida e sotto il marrone rivela ancora viva e brillante la polpa di quando è stato colto. Le bucce di mandarini attorcigliate come unghie finte buttate alla rinfusa su una specchiera. Gli spaghetti freddi e opachi che si attaccano solidi alle porcellane dipinte, pomodoro scuro su paesaggio arcadico, pastorella e capretto, rimasugli di carne su venature di orizzonte bianco sporco.
Bevvero. Bevvero molto.
Così tanto che la giovane si dimenticò di cosa avesse avuto paura. Di non riuscire, di non saper scrivere? Di buttare via una vita così, quando a fianco, giusto nella casa a fianco, viveva un poeta? Che cosa stava facendo? Viveva ogni giorno una menzogna per scrivere ogni notte la verità? Non era meglio sovvertire le cose, nonostante ciò che sarebbe successo, ciò che di tremendo stava forse già succedendo? Per un tratto si riconobbe e si fece paura. Poi se ne scordò di nuovo: che cos’era lei?
Se lo chiedeva anche lui: che cos’era lei? Nel buio, sul canapè, gli aveva sussurrato una parola, e quella gli gravitava nella testa. Che cosa aveva voluto dire con quel discorso? E perché si erano trasferite? Da dove? Erano davvero una coppia? Erano davvero lesbiche? Perché allora aveva sentito qualcosa, quando le era stato vicino? Le potevano piacere anche gli uomini. Vero. Ma era vero? “Guai.” Come se non l’avesse vista quella lunga cicatrice sul polso destro di lei. Continuò a ripetersi, un bicchiere dopo l’altro: “Guai.”
“Visto che non vuoi leggerci niente…” disse Alice.
“Non ho detto che non voglio leggervi niente.”
“Visto che sei un poeta e non ci stai leggendo niente, ti faccio leggere qualcosa io.”
Alice spostò il suo corpo pesante da sotto la sedia, per raggiungere con la mano la tasca dei suoi pantaloni di seta. Aveva negli occhi qualcosa. La sedia fece rumore.
“Che cosa -che cosa–?” Chiese con un sorriso inquieto la ragazza.
“Ho trovato” continuò Alice “il racconto inedito, di una scrittrice poco conosciuta, ma molto, molto talentuosa. Non dico niente. Ti chiedo di leggerlo… come solo un poeta sa fare.”
La ragazza sgranò gli occhi, confusi, sommersi dall’alcol. Aveva riconosciuto una forma, in quel foglio: come le parole occupavano spazi neri dentro al bianco, come un’impronta digitale, come il manto di un animale madre da parte dei suoi animali cuccioli.
Il poeta prese il foglio e cominciò:
“Lettera per A. Firmato Z.”
Fu allora che l’alcol precipitò alla periferia del suo corpo, fu allora che la ragazza si svegliò dal torpore della notte per precipitarsi su quel foglio.
Fu allora che Alice rise, il poeta rise, una bottiglia si rovesciò, la sedia della ragazza cadde, il suo vestito si intralciò nei suoi piedi, a raggiungere le braccia di lui, le mani di lui, il foglio di lei, che lei aveva scritto a mano, appuntato e poggiato sulla sua scrivania al piano di sopra – Alice doveva averlo trovato; no: Alice doveva averlo cercato, rovistando nelle sue cose, sulla sua scrivania, nel suo studio.
Fu allora che il poeta per scansarsi da quell’attacco tonto si alzò in piedi, e poi sulla sedia e poi fu allora che salì con un piede sul tavolo, ridendo, e chiedendo ad Alice:
“Se tu sei A., chi è Zeta?”
Fu allora che Alice rispose: “Non è una Z. È una N. scritta male. Vero Nora?”
La ragazza, cioè Nora, precaria, immobile, annuì: “Dislessica. Te l’avevo detto. Non leggere, ti prego.”
Fu allora che la porta si spalancò, ed entrò un cane.
Quando Audrey entrò nel salone e rovinò a terra, non sembrava nemmeno una cagna che stesse per partorire, sembrava piuttosto uno di quegli animali fantastici nelle miniature medievali, una scrofa diabolica uccisa da San Giorgio, o giù di lì.
È questo che pensò il poeta, ancora in piedi tra il tavolo e la sedia, quando la vide. Lo pensò mentre Nora, urlando, cadeva verso il tavolo, macchiandosi il bel vestito di resti di cibo e vino. Lo pensò mentre Alice tratteneva il respiro, facendosi indietro, accostandosi al tavolo, al suo stinco, ne sentiva la nuca calda vicino alle gambe – è piacevole – anche questo pensò il poeta.
E mentre pensava, sentì i passi soffici e per nulla affrettati di una figura umana, che entrava leggera dal buio della notte, percorreva la penombra dell’anticamera e superato il grande arco del salone, si rivelava alla luce: una donna anziana, un po’ curva, con una borsa in mano e un sorriso – il sorriso imbarazzato di un’ospite che entra credendo di disturbare.
“Che cosa spiacevole” disse la signora anziana “Si vede che non si teneva più” e spostò lo sguardo sulla cagna.
Atreju, il Golden Retriever innocente, aveva iniziato a ringhiare nel momento stesso in cui Audrey era entrata nella stanza. Non ringhiava più innocentemente, però, e Alice se ne accorse, perché disse:
“Cuccia, via, vattene via – Atreju!”
Dalla prospettiva del poeta, la cagna (“Audrey bella” disse la signora tenendosi però a distanza, osservandola con le mani composte sul cuore, come a richiamarla per tornare fuori a giocare in giardino) si era stesa sul fianco, e nel ventre si vedevano muoversi piccoli pomfi. Qualche guaito.
“Signora, il suo cane sta male?”
La padrona di casa si era fatta avanti, incerta, sui suoi tacchi brillanti e dolorosi.
La signora anziana guardò la donna negli occhi. Aveva due pupilline sottili, sotto le palpebre cascanti di carne. Sempre con un sorriso, scosse la testa, come una maestra di scuola benevola al primo giorno di addizioni: “Audrey, non fare la stupida, glielo dici anche tu che non è niente, che poi passa?”
“Signora, questa cagna è incinta. Sta per partorire”. Intuì il poeta.
“Che cosa spiacevole” insistette la signora, con lo stesso sorriso imbarazzato dell’inizio.
Poi finalmente guardò la ragazza giovane, che era rimasta in bilico, tra un tavolo e la sedia. L’aveva lasciata per ultima, ma era la prima, la prescelta. Sul vestito macchiato stavano ancora correndo le gocce rosse del vino, le stavano raggiungendo l’orlo, sarebbe stato un lavoro difficile, pensò, anche per una lavanderia esperta. Ma non le disse niente. Niente, se non:
“Ciao.”
Qualcosa passò tra gli spazi vuoti di quel salone, qualcosa che sentirono tutti. Atreju continuava a ringhiare.
“Non abbia paura.” Alice si sorprese di parlare, mentre muoveva la bocca “Non abbia paura, è buono. Signora, mi scusi, non le ho chiesto niente. Di lei. Dev’essere scioccata. Come sta? Sta bene? Vive qui vicino? No? Non l’ho mai vista, ma… siamo qui da poco, sa noi… Prenda qualcosa da bere. Nora, dai alla signora qualcosa da bere.”
Nora non si mosse.
“Nora. Ci sei? Signora, non si preoccupi. Ci pensiamo noi.”
Dicendo questo, Alice era andata a prendere il cellulare, e parlava a distanza col poeta. In realtà non voleva avvicinarsi.
“Veterinari… aperti ora… cazzo, cosa scrivo. Cosa devo cercare?”
“Una clinica aperta ventiquattr’ore, dai, non è difficile.”
“Non ne trovo.”
“Che cosa cerchi allora?”
“Come far nascere cuccioli di cane. Ci dev’essere un tutorial su YouTube.”
È interessante come gli animali a partorire non facciano il minimo rumore, non emettano il minimo grido, il più piccolo segnale di sofferenza. Non un guaito, non un ululato, non qualcosa che squarci il silenzio, che dica, s’imponga sul mondo come la grande affermazione che le femmine di uomini pronunciano mentre danno alla luce i propri figli: IO STO CREANDO.
No. Generare è relegato a un mero fare, e morire a un mero disfare o disfarsi. Non c’è niente da aggiungere se non l’atto in sé del vivere e dello smettere.
Pensava a questo Nora.
E lo pensava anche il poeta, mentre quattro piccole creature uscivano lentamente e silenziosamente da Audrey, cieche, mugolanti e bagnate.